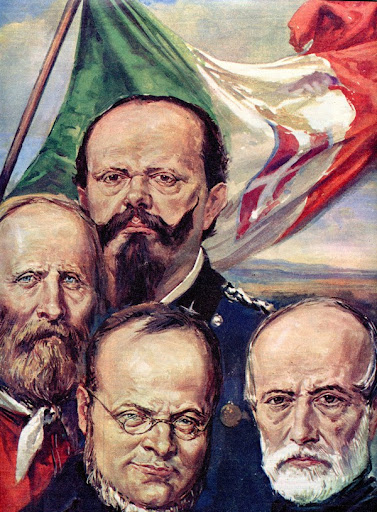di Giuseppe Berti
tratto da “Rinascita – Rassegna di politica e cultura italiana”
Gennaio-Febbraio 1946
Molto si è scritto sugli «aiuti» dell’Inghilterra, della Francia, della Prussia dei quali si sarebbe avvantaggiata, in questo o quel determinato momento, la causa dell’unità, e dell’indipendenza italiana. L’Inghilterra, in realtà, non ci aiutò, né forse avrebbe potuto anche volendo, poiché essa realizzava la sua politica sul continente europeo a mezzo dell’arcireazionaria Austria, la più acerrima e interessata nemica dell’unità e dell’indipendenza italiana. L’Inghilterra – quando ci fu meno ostile e furono rare occasioni – si limitò tutto al più a vaghe dichiarazioni verbali. La Francia e la Prussia, invece, ci aiutarono, in certe determinate circostanze, non certo per spirito di filantropia ma in cerca del loro vantaggio.
Per quanto concerne la Francia l’aiuto dato all’Italia veramente grande, veramente disinteressato, veramente ricco di conseguenze fu la Rivoluzione francese. Aiuto diretto attraverso il lavoro rivoluzionario dei giacobini in Italia. Aiuto indiretto attraverso il movimento grandioso promosso dalla rivoluzione la quale cambiò profonda-mente la natura stessa del «partito delle riforme» italiano e ne fece un partito unitario e rivoluzionario. Sopraggiunta la reazione termidoriana l’Italia ne subì le conseguenze prima attraverso la politica dei tre Direttori e, poi, attraverso la politica brigantesca e spoliatrice dell’occupazione napoleonica la quale portò il nostro Paese sull’orlo della catastrofe.
Nel 1820-21 non ci fu, né ci poteva essere, aiuto francese e perfino nel 1848 quando divenne Ministro degli Esteri il poeta sentimentale della piccola borghesia francese – il romantico Lamartine – suscitando grandi speranze tra i patrioti italiani, in realtà la causa italiana non fece per merito della Francia un solo passo avanti. Il romanticismo è una cosa e la politica un’altra. Lamartine si mostrò un Ministro degli Esteri prudente e codino verso i suoi fratelli di spasimo, i romantici italiani, i quali – Mazzini in testa – erano poi anche fra i capi più influenti del nostro partito democratico. Venne, infine, l’aiuto esitante e non disinteressato di Napoleone III nel 1858-59, ma – come vedremo – l’iniziativa non fu francese ma italiana e russa. Se, in tutto questo periodo, tentativi francesi vi furono d’aiuto alla causa della libertà in Italia vennero non dal governo ma dalla classe operaia. Nel 1867 la Francia di Napoleone III fu contro di noi sui campi di Mentana e solo nel 1870, battuto Napoleone III a Sedan, Roma divenne finalmente, capitale d’ Italia.
La Prussia? La Prussia, reazionaria all’interno e altrettanto reazionaria nella politica estera, fu – è vero – sempre priva di scrupoli allorquando si trattò di manovrare con le forze di sinistra fuori del proprio paese sempre che queste manovre le paressero corrispondere al proprio interesse. Bismarck, ad esempio, trattò non solo col governo costituito italiano ma anche con Mazzini al quale prospettava una politica italo-prussiana (una specie di «Patto d’Acciaio» in anticipo di settant’anni) che se avesse potuto essere tradotta in pratica avrebbe significato la rovina dell’Italia. Bismarck si valse della congiuntura internazionale che aveva messo la Prussia a fianco dell’Italia nel 1866 per conquistare Mazzini all’idea di un’azione comune di vasta portata concertata tra la Prussia e l’Italia: la Prussia nell’Europa centrale e l’Italia nel Mediterraneo. Gli italiani sanno bene, oramai, che cosa significhi questo. Nel 1867, in corrispondenza con Bismarck, Mazzini acconsenti alla tesi di Bismarck secondo la quale tutto il mare Mediterraneo avrebbe dovuto passare sotto l’influenza italiana. Il prezzo sottinteso era l’alleanza con la Prussia, com’è chiaro. Mazzini si rendeva conto dell’indirizzo politico reazionario della politica prussiana e non di meno accoglieva il perfido seme che Bismarck gettava. In conclusione questa temporanea «amicizia» con la Prussia che si era andata stabilendo nel 1866 ebbe una certa tendenza a trasformarsi in una remora pericolosa per l’Italia. A differenza di Mazzini, Garibaldi intuì subito i pericoli di un orientamento filoprussiano e denunciò vigorosamente «il militarismo prussiano perenne terribile minaccia per tutta l’Europa e per la razza latina in specie». Mazzini, invece, diffidava di tutto quello ch’era francese.
Anche nel campo democratico e socialista Mazzini non ebbe che nemici in Francia, cioè proprio nel paese in cui la democrazia era più avanzata. Ebbe nemici quelli stessi che proclamava suoi amici. Un giorno bisognerà rintracciare pazientemente le file della multiforme leggenda sull’aiuto inglese all’Italia durante il Risorgimento italiano. Possibile che poggi tutta sul famoso discorso di Gladstone contro i Borboni di Napoli il cui governo Gladstone definì «negazione di Dio?». In realtà l’Inghilterra o non intervenne affatto o si limitò a dichiarazioni verbali oppure, come avvenne nella più parte dei casi, legata com’era con l’Austria, non solo non aiutò ma ostacolò l’unità e l’indipendenza italiana. Anche il famoso discorso di Gladstone non va messo interamente sul conto delle simpatie inglesi verso il liberalismo italiano. Che l’Inghilterra fosse decisamente contro i Borboni di Napoli è un fatto. Ma è un fatto che non ha niente a che vedere con la presunta simpatia inglese per la causa dell’unità d’ Italia. L’Inghilterra fu contro i Borboni di Napoli perché i Borboni le impedivano di mettere piede in Sicilia. A un fatto storico che non si può contestare che i Borboni e i loro viceré furono il partito più avanzato in Sicilia dal 1781 (dall’epoca del vicereame del principe Caracciolo) sino – quasi direi – al 1830.
La situazione cambiò tra il 1830 e la rivoluzione del 1848. Ma bisogna pur dire che l’anglofilia della Sicilia, la quale durò a lungo e macchiò anche uomini di valore come Ruggiero Settimo (e non fu solo politica ma investì l’economia, i commerci e persino le simpatie filosofiche e letterarie) fu uno dei fatti più malaugurati della storia siciliana. Erano i bruti del feudo, i baroni siciliani che erano anglofili. Disgraziatamente le altre classi poco si facevano sentire e il giacobinismo, che fu un grande movimento nel Napoletano, contò invece in Sicilia pochi isolatissimi martiri. In quanto al decantato Parlamento siciliano, alle decantate libertà sicule, in realtà esse altro non erano che la suprema garanzia del privilegio baronale e un’iniziativa politica inglese intesa a staccare la Sicilia dall’Italia. Ma, lasciando da parte la Sicilia che restò a lungo nell’orbita delle mire imperialistiche inglesi, quale fu l’atteggiamento dell’Inghilterra verso il movimento di indipendenza italiano? Fu questo in poche parole: dal 1789 al 1860.
L’Inghilterra e l’Austria furono le due potenze europee che ininterrottamente – in pace e in guerra – si batterono per mantenere lo status quo europeo. Dove lo status quo venne spezzato (dalla rivoluzione francese o da Napoleone, ad esempio) si batterono per la sua restaurazione. Questa linea di demarcazione (ora più, ora meno netta), corre come un filo nero lungo tutto il periodo della storia di cui scriviamo, e, quindi, non c’è abbaglio da prendere. L’Austria e l’Inghilterra furono sempre, in questo periodo, per la reazione. Quando i liberali inglesi presero il potere cambiò la forma, non la sostanza (cosi come la forma non la sostanza della politica estera inglese è cambiata oggi che Attlee ha sostituito Churchill). Prendete, per esempio, la Rivoluzione francese. Quando il blocco giacobino si spezzò e Danton s’orientò verso la restaurazione monarchica, la lotta tra Danton e Robespierre avvenne non solo sul terreno della politica interna ma della politica estera. Robespierre voleva la pace con la Prussia per continuare la lotta contro la principale nemica della Rivoluzione, contro l’Inghilterra di Pitt e contro l’arcireazionaria Austria, agente inglese sul continente europeo. Danton, invece, era orientato verso I’Inghilterra e l’Austria che rappresentavano in Francia la restaurazione monarchica. Questa linea di demarcazione anglo-austriaca si ripresentò in Italia nei moti del 1820-21, nei moti rivoluzionari del 1848-49 e, infine, nel 1858-59 e persino nel 1860. L’Inghilterra che s’era macchiata – complice Nelson – del sangue degli eroici giacobini napoletani del 1799, del sangue dei fratelli Bandiera che denunziò al governo borbonico, che s’era mossa attraverso l’Austria per fare scacco ai moti costituzionalisti del 1820-21, alle cospirazioni del 1831 e per fare argine alla rivoluzione del 1848, fece anche nel 1858-59 – come vedremo – la sua parte contro il movimento di unificazione italiana.
Se vi fu in Italia un uomo che ammirò profondamente l’economia e l’ordinamento politico e costituzionale inglese quest’uomo fu il conte Cavour. Ma Cavour era un uomo politico e, quindi, immediatamente capi che dalle due potenze interessate al mantenimento dello status quo europeo, che erano l’Austria e I’ Inghilterra, l’Italia non poteva sperare niente. Di conseguenza orientò la sua politica estera in due direzioni: 1) l’alleanza con la Francia; 2) la separazione della Russia dall’Austria e la ricerca d’una intesa e, possibilmente, di una vera e propria alleanza con la Russia. È noto che il 3 febbraio 1855, prendendo a pretesto la tutela degli interessi italiani in Oriente, il piccolo Piemonte interveniva contro la Russia col consenso austriaco a fianco dell’Inghilterra e della Francia, nella guerra di Crimea. Il motivo – comunemente si legge nei libri di storia – sarebbe stato di dare prestigio al Piemonte, di dargli posto nei consessi europei. Ma non s’impegna un paese in guerra per motivi del genere. Il motivo reale che aveva indotto Cavour alla guerra era un altro. Cavour non si faceva illusioni sulla posizione europea del Piemonte. Capiva che rompere la solidarietà dell’Inghilterra e dell’Austria, che aveva dominato mezzo secolo di vita europea, era impresa impossibile. Capiva che fino a che solidale con l’Austria era anche la Russia non vi poteva essere nessuna speranza di provocare una congiuntura internazionale favorevole all’unificazione italiana. Quindi la sua politica si volse a tentare di dissociare la Russia dall’Austria.
In realtà se l’Austria aveva dal 1815 in poi spadroneggiato in Italia fu perché la Russia le aveva dato mano libera nelle cose italiane, nelle quali l’Austria – contando sulla complicità dell’Inghilterra si sentiva completamente sicura. Appena, quindi, cominciò a maturare l’idea di una guerra dell’Inghilterra e della Francia contro la Russia in Crimea, Cavour, alla richiesta inglese che anche il Piemonte vi partecipasse, rispose prima temporeggiando e infine condizionando la partecipazione del Piemonte all’atteggiamento dell’Austria. Se l’Austria fosse stata a fianco della Russia il Piemonte non sarebbe stato così pazzo da coalizzare contro di sé l’odio dell’Austria e della Russia, sapendo bene che la situazione internazionale era tale che esso non avrebbe potuto nemmeno contare, in questo caso, sull’appoggio dell’Inghilterra e, quindi, molto facilmente sarebbe rimasto schiacciato. Perciò l’atteggiamento di Cavour, poco entusiasta per l’intervento in Crimea e, soprattutto l’abile mossa di condizionare l’eventuale intervento del Piemonte non solo alla neutralità ma «all’impegno a fondo!» dell’Austria in Russia era, politica talmente giustificata da non potere essere male considerata da nessuno.
L’Inghilterra che voleva una grande coalizione contro la Russia, visto che il Piemonte era fermo nel condizionare la sua politica a quella dell’Austria si mise a premere energicamente sull’Austria la quale sotto le ripetute pressioni inglesi, e immemore di quanto la Russia aveva fatto per essa, divenne ostile verso la sua vecchia amica e alleata sollevando a Pietroburgo un’ondata d’amarezza e d’indignazione. Era quella che aspettava Cavour. Cavour s’impegnò il meno possibile nella guerra di Crimea e fece noto nei dispacci segreti ai suoi agenti diplomatici, che il Piemonte non aveva nessun interesse a fare guerra alla Russia salvo quello di rompere il blocco austro-russo e di acutizzare i rapporti tra la Russia e l’Inghilterra creando così i presupposti di una futura azione diplomatica del Piemonte. Mossa con successo questa prima pedina, la seconda fu — appena possibile — di stringere i migliori rapporti con la Russia, sulla base dell’ormai comune odio e risentimento contro l’Austria, allo scopo di smantellare le posizioni della dominazione austriaca in Italia. Si potrebbero mettere in fila le numerose istruzioni, i numerosi dispacci che Cavour inviava a questo scopo in quegli anni ai suoi agenti diplomatici. Ma ne abbiamo già dato, in due parole, il succo. Per quanto concerneva l’Inghilterra Cavour, sapendo bene che non se ne poteva fondamentalmente tirar nulla, voleva tuttavia non urtarla nella speranza di poterne ricavare per lo meno una non-ostilità,
Ma queste erano mosse accessorie. Quello che nell’azione di Cavour in quegli anni fu fondamentale fu il deciso orientamento verso la Russia come chiave di volta della soluzione della questione italiana. Cavour s’orientò molto più verso la Russia che verso la Francia. In primo luogo, perché la Francia aveva una frontiera comune col Piemonte: cosa che rendeva la sua amicizia poco disinteressata e, persino, pericolosa. In secondo luogo perché Cavour capiva benissimo che la stessa Francia si poteva muovere più facilmente attraverso Pietroburgo e attraverso il peso della politica e della forza militare russa che non attraverso quel poco che poteva offrire il piccolo Piemonte. Quando Cavour arrivò al congresso di Parigi il terreno era, quindi, già preparato in questo senso. Appena arrivato Cavour trovò modo di legarsi con l’inviato russo, il conte Orlov, e fu proprio Cavour che propose al congresso di Parigi, suscitando l’irritazione inglese, che fosse tolto il blocco decretato dalle potenze occidentali contro la Russia. Proposta importantissima che venne accettata dal congresso e in seguito alla quale il conte Orlov comunicò a Cavour, a nome dello zar Alessandro, che la Russia si rendeva conto che le condizioni italiane erano insopportabili, promettendo la cooperazione politica russa per migliorarle alla prima occasione favorevole. Immaginarsi la gioia di Cavour che vedeva finalmente aprirsi una grande porta dinanzi alla politica piemontese!
Fu in queste contingenze politiche che l’astuto ministro piemontese disse a uno degli inviati russi «che più degli eserciti immensi della Russia il Piemonte si preoccupava del comunismo del mir contadino russo», o qualcosa del genere. Non si può fare a meno di sorridere quando si pensa che Benedetto Croce ha preso questa frase di Cavour per oro colato come se lo statista piemontese si preoccupasse davvero tra il 1848 e il 1860 dell’avvento del comunismo in Russia. In realtà Cavour voleva semplicemente ingraziarsi con questo eccesso d’ortodossia l’inviato dello zar e rassicurarlo circa le idee d’ordine del Piemonte. I risultati di questa politica non si fecero attendere. Ricevendo l’inviato piemontese, generale Dabormida, in quei giorni, lo zar doveva pronunziare la famosa frase: «I rapporti tra le nostre due dinastie saranno d’ora in poi i migliori. Vero è che mio padre è stato un amico troppo solido dell’Austria che l’ha ripagato con la più nera ingratitudine, ma oggi quest’ostacolo è eliminato». L’amicizia e l’appoggio russo erano oramai assicurati al Piemonte. Ma Cavour non era uomo da riposarsi sugli allori e siccome voleva essere sicuro del fatto suo spinse energicamente avanti la cooperazione del Piemonte con la Russia cercando di dimostrare a Pietroburgo che questa amicizia non era per l’Italia una vana parola.
La Russia, battuta dalla formidabile coalizione comprendente quasi si può dire l’Europa intiera, aveva ben dovuto firmare un oneroso trattato di pace, al congresso di Parigi, ma appena firmato il trattato già manovrava per alleggerirne a suo favore le clausole. Cominciarono così le contestazioni circa certe clausole territoriali che riguardavano la città di Bolgrad in Moldavia, e l’isola dei Serpenti all’imboccatura del Danubio, posizione strategica importante. L’Inghilterra interpretava queste clausole nel modo più sfavorevole alla Russia e sollecitavi, il Piemonte ad aderire al proprio punto di vista. Cavour temporeggiò, s’assicurò prima l’appoggio della Francia e quando ne fu sicuro, quando gli parve venuto il momento favorevole, uscì improvvisamente a proporre una soluzione la quale nella sostanza accettava tutte le tesi russe, rendendo così alla Russia un secondo servigio diplomatico. Lo zar ringraziò il ministro piemontese dicendogli: «Che ricordava con piacere i tempi in cui soldati piemontesi e russi combattevano fianco a fianco». Il Ministro degli Esteri russo Gorciakov andò più avanti ancora e fece sapere all’inviato piemontese che avrebbe visto bene una vera e propria alleanza tra il Piemonte e la Russia per l’ingrandimento territoriale del Piemonte e giunse sino a dichiarare che le armi russe, al momento opportuno, avrebbero combattuto volentieri accanto a quelle piemontesi per debellare definitivamente la dominazione austriaca in Italia. Si domandava al Piemonte soltanto l’impegno di non aiutare il movimento rivoluzionario e di mantenere l’ordine. Conquistate oramai queste posizioni Cavour alzò il tono nei confronti dell’Austria. L’Austria rispose violentemente ma finì col rimanere perplessa quando s’avvide che il gabinetto di Pietroburgo parteggiava apertamente per il Piemonte.
Fu nella scia di questa grande politica d’alleanza italo-russa che Cavour s’apprestò al segreto colloquio con Napoleone III a Plombières che come dimostrano gli appunti del senatore Isacco Artom, intimo collaboratore di Cavour (resi noti a suo tempo parzialmente dal figlio) non fu un negoziato a due (limitato, cioè, alla Francia e al Piemonte) ma fu in realtà un negoziato a tre tra il Piemonte, la Francia e la Russia. Uno dei motivi per cui Cavour non volle accettare la pace di Villafranca fu la sua convinzione che la Russia non avrebbe avuto le esitazioni di Napoleone III e sarebbe andata avanti nel suo appoggio delle aspirazioni del Piemonte. In realtà la Russia aveva già fatto molto : aveva mobilitato centomila uomini e li aveva disposti lungo la frontiera austriaca immobilizzando ingenti forze austriache che non poterono essere indirizzate contro l’esercito franco-piemontese. In più s’era adoprata presso Berlino per il non-intervento della Germania e in caso di un intervento della Germania a fianco dell’Austria s’era impegnata ad attaccare la Germania militarmente in aiuto del Piemonte. In cambio la Russia nulla chiese salvo alcune facilitazioni che il Piemonte e la Francia spontaneamente promisero per aiutare con un deposito in un porto francese o italiano il commercio del carbone russo nel Mediterraneo.
L’uomo che realizzò accanto al conte di Cavour questa politica fu il primo israelita italiano levato agli onori del laticlavio e di alte cariche pubbliche: il senatore Isacco Artom allora segretario generale del Ministero degli Esteri. Scrisse l’Artom, a conclusione dei suoi appunti: «La Russia mantenne lealmente i suoi impegni e la sua azione fu della più alta importanza, sia nel periodo precedente all’apertura delle ostilità sia durante la guerra fino alla pace di Villafranca. La storia diplomatica di quell’affannoso periodo che va dal gennaio all’aprile del 1859, in cui lo scambio di note e dispacci fu vertiginoso, non è ancora stata scritta anche perché molti documenti dovranno per lungo tempo rimanere segreti. Ma non è indiscrezione rivelare che si dovette soprattutto all’atteggiamento risoluto della Russia se fallì la missione Cowley presso le varie corti di Europa diretta ad impedire che la questione italiana venisse ad essere sollevata. La Russia, opponendosi alle pratiche officiose del governo inglese, propose invece la convocazione di un congresso per sciogliere la questione italiana la quale diventava cosi questione europea. L’azione della Russia fu particolarmente decisiva altresì nei giorni susseguenti all’invio dell’ultimatum austriaco al governo piemontese. È noto che l’Austria la quale si attendeva forse una risposta meno risoluta di quella data dal conte di Cavour all’ultimatum presentato dal barone di Kellesberg, aveva offerto all’Inghilterra di farsi mediatrice del conflitto, disposta ad accettare le prime proposte, presentate da Lord Cowley alla corte di Vienna; e poco prima rifiutate. L’Inghilterra aveva subito accolto con premura l’occasione di stornare la procella che si avanzava sull’orizzonte europeo ed agiva vigorosamente presso i vari gabinetti europei per farli aderire al suo tentativo pacifico. Il conte di Cavour aveva presentito il pericolo intuendolo non per la conoscenza delle pratiche segretissime fatte dall’Inghilterra, ma perché alla scadenza dell’ultimatum gli austriaci non si erano mossi. Trascorsero ore che parvero secoli. Ricorderò sempre quei momenti angosciosi in cui sembrava dovere cadere inesorabilmente la mirabile opera diplomatica con cui il conte di Cavour, con lavoro immane, aveva potuto indurre l’Austria a dichiarare la guerra. Finalmente giunse la notizia che il maresciallo Giulay aveva avuto ordine di avanzare. La proposta inglese era caduta ed era caduta segnatamente per l’opposizione incontrata nel gabinetto di Pietroburgo, il quale non solo respinse le aperture dell’Inghilterra, ma dichiarò che di fronte all’ultimatum austriaco riteneva inutile ogni ulteriore tentativo pacifico, riservandosi intiera libertà di azione. Immediatamente dopo l’apertura delle ostilità la Russia ordinò la chiamata delle riserve e la mobilitazione delle sue truppe verso la frontiera austro-russa. Questi grandi servigi resi dalla politica russa e dalla intiera famiglia slava alla causa della indipendenza d’Italia dovranno essere segnalati dagli storici futuri alla perenne riconoscenza degli Italiani».
Questi i fatti che suggeriscono le conclusioni seguenti: primo, la politica d’amicizia italo-russa fu la politica fondamentale di quel primo nucleo dello Stato italiano che fu lo Stato piemontese. Essa ebbe lontani antecedenti e continuò dopo la morte di Cavour, nel 1866, e dopo. Nel 1866 le cose vennero complicate dal fatto che contro l’Austria – questa volta – si schierava non soltanto l’Italia ma la Prussia. E la Russia desiderava, certamente, che fosse battuta l’Austria e simpatizzava con le rivendicazioni italiane, ma non vedeva con simpatia l’egemonia prussiana sui popoli tedeschi e il rafforzamento della Prussia. Con tutte le limitazioni che questa situazione internazionale imponeva la Russia, tuttavia, ci appoggiò e ci sostenne anche nel 1866. ‘La politica di amicizia italo-russa fu, dunque, antecedente a Cavour e posteriore a Cavour. Secondo, nel corso del Risorgimento risaltano due elementi positivi fondamentali. Il primo fu il movimento democratico italiano che – per battuto e represso che fosse, fece muovere al nostro popolo i primi passi e gettò semi fecondi nella storia e nella tradizione del nostro paese, dai quali poi germogliarono le correnti più avanzate della democrazia e del socialismo italiano e sul cui terreno, oggi, noi comunisti. stessi ci muoviamo e siamo. È questa tradizione democratica – che nemmeno venti anni di fascismo sono riusciti a soffocare – che ha contribuito a rendere il nostro destino differente da quello sciagurato della Germania. Il secondo elemento positivo del nostro Risorgimento venne dato innegabilmente dalla politica estera dello Stato piemontese, anche se, questa politica estera manovrava in maniera di contenere e reprimere all’interno le forze democratiche.
Le forze democratiche ebbero, in Italia, una politica estera concreta soltanto durante la Rivoluzione francese: quando si pensava ad una repubblica italiana sorta sull’esempio di quella francese e col favore di una congiuntura rivoluzionaria europea. A mano a mano che le imprese napoleoniche dissipavano queste illusioni i giacobini italiani abbandonavano queste speranze e si orientavano verso una nuova linea in politica estera. Dopo il 1799 furono i giacobini italiani, difatti, a coniare in Italia la parola d’ordine famosa «l’Italia farà da sé» la quale rimase, poi, viva nella politica democratica e mazziniana della «Giovane Italia» sino al 1860. Grandi speranze suscitò il 1848 europeo. In realtà, la borghesia – caduto nel 1794 il blocco giacobino in Francia – mai più si presentò sulla ribalta della storia come una forza rivoluzionaria di carattere internazionale. Nemmeno nel 1848. E dopo il 1848-49 s’orientò dappertutto verso il compromesso con le forze moderate e conservatrici. Il movimento democratico non potette, quindi, avere (e non ebbe) una politica estera che potesse concretamente aiutare l’indipendenza e l’unità italiana.
Non poteva orientarsi verso Napoleone III e verso la Russia zarista (ricordarsi dell’atteggiamento di Mazzini nel 1859) e, a maggior ragione, non poteva orientarsi verso il blocco austro-inglese che manteneva schiava e divisa l’Italia. Quindi, la politica estera democratica fu sterile – chiusa in declamazioni retoriche e in affermazioni di principio infeconde. Questa fu la grande tragedia della democrazia italiana, e questo provocò la grande rottura nelle file democratiche. Ad esempio, il passaggio sia pur temporaneo e condizionato di Garibaldi nel 1859 e nel 1860 sulle posizioni della monarchia piemontese.
Oggi insieme ai problemi fondamentali della nostra politica interna si ripresentano i problemi fondamentali della nostra politica estera, perché oggi siamo di nuovo ad una svolta della nostra storia. Ma oggi – dopo l’Ottobre 1917, dopo questa guerra – mutati sono i termini della situazione europea. Il movimento democratico italiano oggi può avere una politica interna e una politica estera conseguenti, e al tempo stesso, concrete, realistiche, rispondenti agli interessi fondamentali dello Stato italiano. La rottura politica del nostro Risorgimento oggi non si ripeterà. Da qui la garanzia dei futuri successi della democrazia in Italia. Da qui l’importanza politica essenziale di una giusta comprensione del problema dei rapporti tra la Russia e l’Italia.